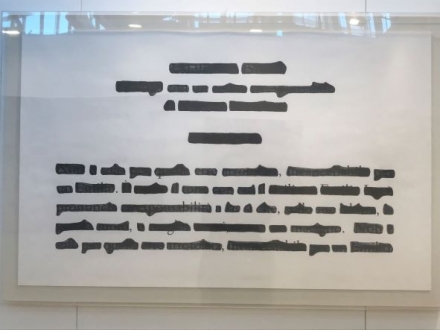The shape of water. Una favola che esalta il cinema e si scaglia contro il razzismo. Ma il messaggio sembra prevalere sulla forma cinematografica

The shape of water, nonostante sia un progetto al quale Guillermo del Toro lavora da almeno 7 anni, ha il sapore dell’opera costruita con lo scopo di allargare il proprio bacino di pubblico e raggiungere le grandi masse senza sacrificare troppo la propria poetica.
Del Toro, rifacendosi direttamente a Il mostro della laguna nera di Jack Arnold, rivisita, per l’ennesima volta, la favola de la bella e la bestia e crea un film classico con una trama lineare e semplice basata su divisioni chiare e nette.
Tuttavia, forse anche per l’epoca storica in cui cade il film (la presidenza di Trump) la pellicola è molto più complessa e stratificata di quanto non possa apparire.
The shape of water, innanzitutto, è un’ode al cinema e alla sua capacità di creare mondi e di far sognare.
Non a caso la protagonista Elisa Esposito (Sally Hawkins) ed il suo vicino Giles (Richard Jenkins) spesso guadano vecchi film alla televisione e vivono sopra un cinema.
La sala cinematografica è un vero e proprio tempio, oramai privo di spettatori, che lentamente cede il passo alla televisione.
Nonostante ciò continua ad irradiare il suo potere come dimostra l’ultima cena tra Elisa ed il mostro (Doug Jones) in cui la ragazza, che è muta, immagina di esprimere il suo amore per la creatura attraverso una canzone che Del Toro trasforma in un omaggio ai vecchi musical in bianco e nero.
Al tempo stesso il film frulla i generi mescolandoli tra loro. La storia d’amore ed il melodramma si intersecano con la fantascienza ed il film di spionaggio.
Eppure, paradossalmente, stavolta Del Toro appare poco convinto delle sue straordinarie capacità.
Nonostante una forma perfetta ed una cura certosina per le scenografie ed i dettagli, troppo spesso il film appare eccessivamente didascalico, come se il regista sentisse continuamente il bisogno di esplicitare il proprio messaggio nella paura che i mezzi propri del cinema non siano sufficientemente in grado di renderlo chiaro ed intellegibile a tutti.
Intendiamoci, le ossessioni di Del Toro sono tutte presenti nel suo ultimo lungometraggio.
La capacità di intersecare periodi storici particolari con la dimensione fantastica o l’amore per la tecnologia retrò ed un po’ scalcinata li ritroviamo anche stavolta.
Però sono tanti i momenti in cui il film diventa ridondante.
Un esempio perfetto è il dialogo tra Giles ed il mostro in cui, esplicitamente, il vecchio illustratore omosessuale dice che entrambi sono dei relitti.
Lo stesso dicasi del momento in cui Elisa scopre la sua attrazione per l’uomo anfibio.
Mentre fugge dall’oggetto del desiderio, i suoi sentimenti sono esplicitati attraverso i dialoghi provenienti dal cinema sottostante, come se il regista temesse che la sequenza in sé non parlasse da sola.
Altre volte il film è tanto ridondante da sfiorare addirittura il grottesco, come nel dialogo tra Elisa e Giles in cui, invece di affidarsi a dei sottotitoli, Del Toro fa ripetere al vecchio signore il dialogo muto della ragazza.
Anche la sceneggiatura, alle volte, sembra insicura di sé.
L’esempio più lampante sono i segni che Elisa ha sul collo, la cui vera natura è chiara sin da subito.
Ancora una volta però Del Toro si sente insicuro e così lascia che Zelda (Octavia Spencer), la collega di Elisa, spieghi al perfido Strickland (Michael Shannon) che la ragazza è un’orfana ritrovata vicino al fiume. Dettaglio sin troppo rivelatore.
Infine anche sul piano visivo il film si affida ad una dicotomia sin troppo esplicita.
Da una parte i buoni, compreso il dottor Hoffstetler (Michael Stuhlbarg), che vivono tutti in un mondo volutamente decadente e sporco, tra pareti scrostate e tetti da cui filtra la pioggia. Tra appartamenti vuoti e strade buie, in case piene di oggetti poste sopra vecchi cinema deserti.
Dall’altra parte c’è il mondo colorato e scintillante in cui vive Strickland, tutto colori pastello, tra Cadillac nuovissime, pubblicità scintillanti e case perfette inondate di luce.
L’impressione è che insomma Del Toro abbia badato troppo al messaggio finendo così con il realizzare un film che, nonostante tutto, appare come il meno personale tra quelli da lui girati.
I buoni di questo film sono tutti dei diversi e degli esclusi.
Un uomo anfibio, un illustratore omosessuale senza lavoro, una donna di colore con un marito fannullone, una ragazza sola e muta.
Persone che non sembrano avere diritto di cittadinanza nell’America degli anni ’60.
Così l’impossibile amore di Giles nei confronti del ragazzo della pasticceria si scontra contro il razzismo di quest’ultimo mentre le donne di questa storia sono relegate ai margini, sguattere che possono solo pulire i pavimenti dall’urina degli uomini o passare il loro tempo a cucinare per mariti che non abbandonano mai la poltrona.
È sin troppo chiaro che il vero destinatario del film sia Trump e la sua politica, soprattutto perché Del Toro ha origini messicane.
Purtroppo l’ansia nei confronti dell’aspetto “politico” del film ha fatto sì che Del Toro abbia abdicato ad un pezzo importante della sua anima ed abbia realizzato un film addomesticato e normalizzato, in cui tra le tante citazioni, rivive forse troppo l’impressione di assistere ad una nuova versione de Il favoloso mondo di Amélie o ad un film di Tim Burton in cui la componente fantastica appare schiacciata dalla volontà di piacere a tutti.